I Fear mettono subito le cose in chiaro. L’assalto frontale della corazzata Let’s have a war abbatte in un attimo tutte le sterili discussioni su cosa sia o non sia il punk-hardcore, sui suoi primati storici, sulla sua fondazione. Le opere perfette “fondano e liquidano un genere nello stesso momento”, di questo era convinto Walter Benjamin e, se non fosse fuori luogo in mezzo a tanto degrado morale e sonoro, questo disco si potrebbe definire perfetto.
Omofobi, cafoni, misogini, razzisti, blasfemi; ad ascoltare i testi di questi quattro scalmanati si direbbe di essere di fronte ai peggiori piantagrane da birreria. Ed in parte, almeno a giudicare da quello che succedeva durante le loro esibizioni, non ci si sbaglierebbe. Tuttavia, solo in parte. Sì perché se si dirige l’attenzione verso la musica, che è il vero piatto forte di questo disco, ci si accorge immediatamente di essere di fronte ad uno dei dischi, se non al disco più avanguardistico del punk-hardcore tutto. Si è fin troppo insistito sulle influenze blues sulla formazione, in realtà molto marginali e riscontrabili solo in alcune venature vocali, che solo saltuariamente prendono congedo dal consueto grugnito gutturale, comunque già di per se molto al di sopra della media del genere per varietà ed intelligenza d’uso, per assumere le torbide tinte del delta. Questa sopravvalutazione dell’influenza blues una volta di più il patetico glotto-centrismo della critica, che mai come in questa cosa mancherebbe il bersaglio sottovalutando l’aspetto strumentale. The record è infatti da questo punto di vista una cornucopia di invenzioni, un vero e proprio repertorio di creatività punk. A partire da un hardcore fortemente colluso con il garage più balordo, il disco si muove in ogni direzione concepibile, trovando sempre soluzioni più che felici. Ma, fughiamo ogni dubbio, la vocazione più genuina di questo disco è quella sperimentale. Dissonanze, cambi di tempo e di registro inattesi, noise dilagante, atonalità, un uso del tutto innovativo del linguaggio musicale di base, che tende a rovesciare parodisticamente il serio in comico e viceversa. La maestria con cui infilano una scala arabeggiante nel bel mezzo del riff asimmetrico del math-rock ante-litteram di Camarillo, ci fa dubitare se il brano sia stato scritto veramente dallo stesso gruppo che in Fresh flesh canta: I wanna fuck you to death/I don’t wanna smell your breath/Piss on your warm embrace!/I just wanna cum in your face! Ma proprio quest’ultimo brano mette in campo un’artiglieria trash-metal di raro equilibrio tra punk e metal. Difficile poi descrivere l’effetto straniante della messa alla berlina dell’ambiente radical chic newyorkese, che si lancia a rotta di collo su un giro grottesco sfigurato da un inatteso sax free-jazz, tra l’altro proprio nei momenti in cui Lee Ving sbeffeggia l’intelighenzia della grande mela ironizzando: New York’s alright if you like saxophones.
Il sole della California deve fare veramente male, se si considera che da questa patria di spiagge, ragazze in bikini e pattini in linea provengono anche quegli altri impareggiabili terroristi del punk-hardcore, i Black Flag. Ma i Fear vanno oltre. Se i primi sono la rabbia, i secondi la decomposizione. Difficile scorgere un raggio di sole in questa decostruzione permanente del linguaggio del punk. Questi tipi fanno veramente paura, e spaventano per il semplice motivo che è evidente che la loro musica non voglia semplicemente divertire. Sono lontani anni-luce dall’essere un gruppo di rock-demenziale, aggettivo cui talvolta sono stati associati. Il loro effetto è piuttosto simile al filtro deposto sulla realtà dalla scrittura kafkiana, in cui tutti gli elementi sono prosaici, quotidiani, realistici persino, ma nessuna cosa si trova al suo posto. E il disco tocca i suoi vertici proprio laddove si fa più cerebrale. Disconnected si disconnette in modo stralunato, rallentando improvvisamente e creando un effetto di distorsione percettiva, disseminando periodici buchi neri tra le maglie di un apparentemente ordinario tessuto punk. Getting the brush sembra tentare ormai semplicemente la messa in musica di una perdita di sensi, anche se propriamente tenta di simulare la “pera” di eroina che un ragazzo frignone e viziato si inietta. Il giro di chitarra che, interrotto solo dalle consuete dissonanze, attraversa We got to get out of this place altro poi non è che un verme che si contorce nella mente di un pazzo.
Nella folle operazione di destrutturazione dei Fear ci si può certo imbattere in momenti (più apprezzati di quanto meritino ma più rari di quanto si creda) di chiassosa baldoria da stadio. Tuttavia non possono esserci dubbi, anch’essi sono funzionali al loro collage dadaista. I Fear hanno coniato una formula di art-hardcore (si potrebbe utilizzare il termine ruffiano: art-core) in cui diversi linguaggi musicali vengono smantellati e rimontati in modo tale da mutarne radicalmente il senso. Kracauer attribuiva questa possibilità al cinema che, laddove guidato da una coscienza emancipata, può dissolvere gli elementi organici e naturali per compenetrarli con la ragione. I Fear, nel loro piccolo, come il cinema, sono un’espressione eminente della modernità, quella che, come se non fosse già abbastanza moderna di per sé, oggi si vede così spesso apporre il suffisso post-. Dimostrano che, anche un genere così apparentemente brutale e schiavo degli istinti più immediati e inelaborati, può essere vulnerabile ad una coscienza trasformativa, che non accetti passivamente ciò che le proviene dal materiale dato. Ciò, a suo particolarissimo modo, può redimere anche tutta le volgarità debosciate e xenofobe che trasudano dai testi di questo album. Anche queste infatti (che siano pronunciate con intenzione ironica, seria, provocatoria o furba non è importante) divengono i pannelli di questo grande quadro schizoide che è The record.



















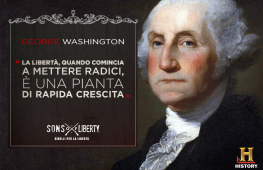


Recent Comments