In Italia il primo maggio 2015 non lo scorderemo facilmente. È stato diverso da ogni altro primo maggio. È stato il primo maggio dell’EXPO e dei NO-EXPO, della profanazione del Canto degli Italiani e della violenza dei contestatori di professione. Un primo maggio che è stato tutto fuorché la festa del lavoro. In sintesi, a uno sguardo attento, questo primo maggio si candida a divenire la data simbolo della deriva nichilistica di un’intera nazione ormai farsescamente allo sbando.
Partiamo dall’inno. Forse a livello giuridico, anche volendolo, sarebbe impossibile punire i responsabili della storpiatura di uno dei versi più significativi del testo di Mameli (il «Siam pronti alla morte» cambiato in «Siam pronti alla vita»), ma sotto un profilo politico, culturale e morale questa “renzata” merita di essere definita una vergogna che, più in profondità, rivela la somma tristezza di quest’epoca edonista ed individualista. Infatti cosa c’è di più ignobile dell’omettere, nel corso della cerimonia inaugurale di un evento che dovrebbe rilanciare la nostra nazione, una parola che, nella sua tragicità, testimonia il massimo grado dell’amore per la propria patria? È vero, in quest’epoca la parola morte fa paura (eccezion fatta, per le sensibilità liberal, quando provocata dall’eutanasia o dall’aborto). La morte evoca sofferenza e sacrificio, cose che fanno tremare i polsi specie a chi è cresciuto con l’illusione, tutta occidentale e tutta contemporanea, della “ricerca della felicità” come unico scopo della vita. Non è facile spiegare, come ebbe scandalosamente a fare Aleksandr Solženičyn dalla cattedra di Harvard nel 1978, con la sua barba da saggio russo d’altri tempi, che «se l’uomo fosse nato, come sostiene l’umanesimo, solo per la felicità, non sarebbe nato anche per la morte. Ma poiché è corporalmente votato alla morte, il suo compito su questa terra non può essere che ancor più spirituale: non l’ingozzarsi di quotidianità, non la ricerca dei sistemi migliori di acquisizione, e poi di spensierata dilapidazione, dei beni materiali, ma il compimento di un duro e permanente dovere, così che l’intero cammino della nostra vita diventi l’esperienza di un’ascesa soprattutto morale: che ci trovi, al termine del cammino, creature più elevate di quanto non fossimo nell’intraprenderlo».
Rimuovere dall’inno italiano la parola morte, sublimazione massima del sacrificio per un ideale più grande della vita stessa, non è solo cattivo gusto, ma espressione del rivoltante nonsenso nichilistico dell’epoca odierna, avvolta da una cappa di materialismo che tutto fagocita e tutto rovina: dalle sovranità degli Stati alle relazioni tra i sessi. Somma ignoranza poi se si pensa che l’Italia pone le sue fondamenta di lingua e cultura proprio sulla riflessione su morte e aldilà della “Divina Commedia” dantesca, nonché la propria mitologia patriottica sui foscoliani “Sepolcri”. Somma offesa alla nostra identità se si pensa che dalla canzone “All’Italia” di Leopardi all’estetismo guerresco di D’Annunzio, la mistica della patria italiana risulta inscindibile dal richiamo al sacrificio supremo che, come un filo rosso di sangue, unisce i momenti focali della nostra storia nazionale. Ma del resto, ad essere cinici, rinunciare al grido «siam pronti alla morte» è anche l’ammissione di una grande verità: oggi, in Italia e in gran parte dell’Occidente, chi sarebbe disposto a morire per un ideale come la patria o la fede? Probabilmente in pochissimi. E questo è ciò che rende miserabile la nostra epoca più di ogni altra cosa. E quello che ci rende più deboli e vulnerabili nei confronti di chi invece possiede, seppur spesso in maniera scomposta e storpiata, un’identità forte e radicata. Spiritualmente desertificato dal capitalismo post-borghese, l’Occidente crede ormai solo nelle mai soddisfatte voglie dell’io, spinte al più grottesco parossismo. Tuttavia anche il «siam pronti ealla vita» suscita perplessità: a quale vita dovrebbero essere pronti, per esempio, i giovani italiani, immersi in un eterno provvisorio, privi di lavoro o schiacciati dalla precarietà, impossibilitati o quasi a costruire una famiglia e progetti stabili? «Siam pronti alla sopravvivenza» sarebbe stato sicuramente più corretto.
Nelle sue “Lezioni spirituali per giovani samurai” Yukio Mishima scriveva:
«noi viviamo in un’epoca di esistenze assolutamente fiacche ed ambigue. Raramente incontriamo la morte, la medicina ha compiuto enormi progressi ed i giovani non temono più né la tisi, che decimava gli organismi più deboli, né l’arruolamento, che intimoriva i ventenni delle epoche trascorse. In mancanza di pericoli mortali, l’unico modo in cui i giovani riescono ad assaporare la sensazione di essere vivi è la ricerca forsennata del sesso, oppure la partecipazione a movimenti politici, motivata semplicemente dal desiderio di esercitare la violenza».
Non occorre generalizzare, ma mai parole furono più adatte a spiegare la furia vandalica dei black bloc che hanno messo a ferro e fuoco Milano. Per loro, deteriori sottoprodotti del sessantottismo militante, la politica è solo una scusante per sfogare un desiderio di violenza frutto di mancanza di senso, noia e frustrazione. Cosa aspettarsi del resto da chi contesta la globalizzazione e l’americanismo su basi anarcoidi, libertarie o post-trotzkiste tutt’altro che alternative all’ideologia dominante? Un’ideologia che, per dirla con Costanzo Preve, fa da supporto al nuovo «ipercapitalismo liberalizzato post-borghese e post-proletario, all’insegna della grottesca teologia sociologica del “vietato vietare”», avente nella cosiddetta “controcultura” americana e nel ’68 europeo i propri miti fondativi. C’è quindi un filo rosso (non di sangue!) che lega, inconsapevolmente o meno, il renzismo obamiano e i devastatori delle strade milanesi. Entrambi impensabili senza l’americanismo, entrambi nemici dell’Italia. Quell’Italia per cui non si è più pronti alla morte.



















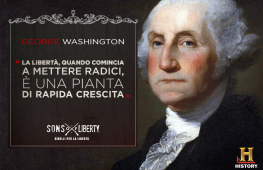


Recent Comments