A
Regia: Luca Ferri
Anno: 2015
Durata: 85′
Nazione: Italia
Interpreti: Dario Bacis
RECENSIONE
Tra le rivelazioni delle uscite degli ultimi mesi, “Abacuc” di Luca Ferri (nelle sale dal 2 novembre) riprende in mano il filo reciso del cinema cosiddetto sperimentale per costruire, o decostruire, un viaggio grottesco nel Nord Italia dominato da scempi urbanistici e edili di ogni tipo, viaggio al termine della notte alla fine del quale non rimane che rifugiarsi nel cimitero, luogo-simbolo della morte di ciò che è stato definito postmoderno (e, per dirla con l’ultimo Houellebecq, morte dell’intera civiltà occidentale, finalmente accordata all’etimo che la vuole assimilata al concetto di tramonto). Un tramonto ferocemente iconoclasta, quello intessuto dalle immagini in bianco e nero girate in super8 da Ferri e dalla colonna sonora analogica e post-atomica del compositore Dario Agazzi, che non rinuncia però al taglio sarcastico fatto di fendenti ora apparentati al teatro dell’assurdo (“Io leggo Lacan”, ci confessa lo scheletro affrescato) ora provocatori (“Chi ascolta jazz è un eiaculatore precoce”; ”Paradossi delle reliquie: i prepuzi di Gesù erano dodici”).

Film sulle rovine e sulla monumentalità della rovine, come ha avuto modo di scrivere il suo autore, Abacuc vede come protagonista un uomo di duecento chili, quasi immobile, lontano dalle emozioni e dalla parola, protagonista di una sorta di remake di “L’ultimo uomo sulla terra”; Abacuc è un Buster Keaton oltre il declino, è il cadavere di Keaton che si aggira in un Paese ormai tumefatto. Come il Jack Nance di Eraserhead, vive in una piéce che ne racconta allo stesso tempo la condizione di superstite e di testimone dello stato terminale di un’epoca: non rimane che sperare, spogliando un petalo dopo l’altro una margherita nel mi-ama-non-mi-ama fanciullesco, che ci sia (ancora) qualcuno ad amarlo.

Abacuc si pone, o è posto, a tutti gli effetti come una marionetta senza spettatore, catapultato al centro di un teatro finzionale che cortocircuita con la realtà, squarciandola e rivoltandola su se stessa. Nessun tipo di costruzione narrativa è più possibile: ad Abacuc e al suo vago pellegrinare non resta che ascoltare una voce meccanica ad una cornetta che, attraverso la reiterazione di citazioni del passato, lo conduce ad un continuo e inesorabile vicolo cieco, al termine del quale il linguaggio perde la sua valenza di segno e di testimonianza. Cosa rimane? Rimangono la contemplazione estetica, le macerie dei secoli, i volti dei defunti esposti sulle lapidi accompagnati da improbabili storie, montate e rimontate casualmente come in una letteratura combinatoria mortifera. Non è finzione e non è documentario: siamo nella frattura, nella lacuna, nel buco nero del linguaggio.

“La musica, come tutte le arti, ha l’umile compito di descrivere la propria fine”, ci suggerisce la voce meccanica che accompagna l’esistenza di Abacuc. E il cinema di Ferri sembra voler inseguire il suo protagonista, la sua marionetta, proprio verso la fine di ogni modalità della rappresentazione. L’arte cinematografica deve implodere in se stessa, ricercare le proprie rovine (si agita il cadavere di Walter Benjamin) e, una volta trovata la propria estinzione, sperare in una rinascita. Abacuc si pone in questo senso come un superamento totale (e totalizzante) della storia del cinema: è slapstick comedy ma è oltre, è cinema delle avanguardie ma è oltre, è documentario ma è oltre, è soprattutto racconto post-moderno, ma oltre. Col suo lungo canto funebre, in questo Kaddish per immagini e musiche, Ferri firma un atto fortemente politico, uno sguardo allarmato e provocatorio sul cinema contemporaneo, spogliandolo delle facili epiche quotidiane e riportando l’attenzione sulla funzione espressiva e quasi oltraggiosa dell’occhio cinematografico, che qui assume le sembianze del volto incancellabile di Abacuc.
Voto: 8
Stefano Malosso


















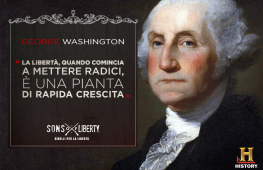


Recent Comments